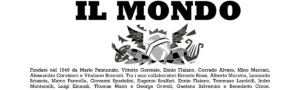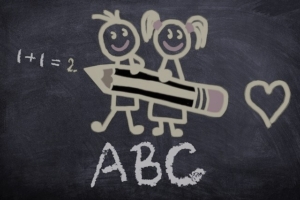SCUOLA
LE NUOVE PAROLE DELL’EMERGENZA: EDUCAZIONE, SCUOLA, GIUSTIZIA
Luisa Piarulli
Non c’è cambiamento quando si continua ad agire in forma emergenziale, ovvero restando in superficie.
[…] Che ciascuno faccia, a suo modo,
i primi passi sulla strada che conduce alla fontana di Siloë ,
alle radici stessi della persona […][1]
(Gaston Bachelard)
Nessuno avrebbe mai immaginato che la propria vita sarebbe stata sconvolta da un virus, il Sars Covid 2. Un vero e proprio stravolgimento esistenziale e planetario. In pochi mesi i progetti, gli investimenti, la regolare quotidianità sembrano essere andati in frantumi e le giornate, seppure annoiate, o stanche, o monotone, non lasciano più la certezza del domani. Incalzano discorsi e parole il più delle volte spogli di reali contenuti, ripetuti meccanicamente, così come le promesse ricorrenti che poco tutelano la vita di ogni cittadino. Si va insinuando una preoccupante tendenza demagogica. È tempo di pensare per comprendere, per dare senso a tutto, perché il tutto va oltre la somma delle piccole parti, andando oltre le ragioni economiche, oltre quelle medico- sanitarie. Riprendiamo dalle parole. Il termine attualmente più in voga è “emergenza”, dal latino emergere, composto di e fuori e mergere, affondare, tuffare. Le etimologie, come sempre, ci offrono panorami di significati che vanno ben oltre il senso comune. L’emergenza, a ben vedere, non nasce dal nulla, non è inaspettata e, paradossalmente, potrebbe anche essere foriera di cose belle. Viene da pensare alla Nascita di Venere, del Botticelli, un’opera nella quale la dea posta delicatamente su una conchiglia, avanza con grazia e leggerezza sul mare lievemente increspato dalle onde. Come a dire che dal mare possono emergere apparizioni deifiche e improvvise che fanno bene al cuore e sono promessa di fioriture. Ma in questo nostro tempo non è emerso nulla di buono. I fiumi straripano oppure si inaridiscono, i vulcani spenti da ottocento anni (Islanda) riprendono vigore d’improvviso, gli tsunami sconvolgono i villaggi, l’acqua non è per tutti e la foresta amazzonica, polmone del pianeta, viene vandalizzata, i ghiacciai si sciolgono e la conformazione della Terra inevitabilmente assume un’altra forma. L’ecosistema è in dis-equilibrio e la natura si ribella. Nel nostro tempo, l’essere umano, tormentato dal bisogno di potere ha preteso di appropriarsi di ogni risorsa disponibile e di dominare la terra, il mare, il cielo, gli altri esseri viventi, come a sentirsi padrone di ogni cosa, crogiolandosi nel benessere e nel consumismo a discapito di tanti, troppi che il minimo non l’avevano. È bastato un virus e il re è nudo. Sono emersi, come d’improvviso, il disorientamento, la paura, l’incertezza e una oramai insopportabile solitudine in obbedienza alla regola del distanziamento sociale, tentando, i più, di proteggersi da un nemico invisibile e subdolo. Non più la Venere. Ora bisognerà salvarsi e non basterà di certo un vaccino. C’è bisogno di giustizia sociale, c’è bisogno di ri-acquisire fiducia nell’intelligenza di ogni essere umano, di tornare a vivere con una nuova consapevolezza, imparando il rispetto verso ogni forma vivente. Certo, sembra utopico tutto ciò. Ma l’utopia educativa è la sola speranza di trasformazione, ovvero ricominciare a respirare tratteggiando in modo altro la nostra esistenza, che non è malattia, non è robotica, non è psicosi della sindrome. Esistere è un termine bellissimo e implica il riconoscimento e la dignità della Persona, pro-muove l’incontro, la presenza del Volto dell’Altro, sollecita idee, emozioni, talenti e attitudini al servizio di sé e della comunità. L’essere umano è “un essere non finito”, permanentemente aperto alle influenze e alle sollecitazioni sociali e culturali, alle contraddizioni, all’incontro con gli ostacoli e le barriere, tuttavia la persona è trascendenza, va oltre il contesto e la situazione contingente e sa ri-creare. Ogni attimo di vita richiede un nuovo equilibrio e la storia umana ci insegna che si cade ma ci si rialza, si distrugge ma si è capaci di ri-costruire, purché venga restituita a ognuno la possibilità di creare, di pensare, di ricoprire un ruolo di protagonismo, di fare, di essere, di agire, di comunicare, di relazionarsi. In una parola di esistere nel rispetto e nella reciprocità. Riprendiamo dalla scuola, la “grande dimenticata”. Mi sono imbattuta in un testo dal sapore reazionario e da alcuni definito complottista, scritto da Jean-Claude Michéa, “L’insegnamento dell’ignoranza”[2] nel quale l’autore avalla l’ipotesi che i nostri studenti vengano volutamente indottrinati all’ignoranza. Una lettura che lascia perplessi, seppure sia evidente il basso livello culturale dei nostri giovani rispetto ai nostri padri che terminavano la quinta elementare del tempo. La superficialità e lo sguardo miope dei più giustificano questa situazione denunciando le falle dell’insegnamento, una spiegazione semplicistica che umilia le decine di insegnanti che professano l’arte della docenza. Va invece detto che nella scuola si sono moltiplicati nel tempo gli elementi “disturbanti” che hanno prodotto de-motivazione e disincentivazione verso l’insegnamento stesso: i processi di esasperata burocratizzazione dell’istituzione scolastica, le riforme ministeriali a rotazione, le responsabilità penali e civili di cui docenti e dirigenti scolastici sono stati investiti, la mancanza pluridecennale di un dignitoso riconoscimento sociale, culturale ed economico dei docenti, l’imponente ondata di delega educativa, la mancanza di fattualità del patto educativo scuola-famiglia.
[1] Bachelard G., La dialectique de la durée, (1936), trad. a cura di Carlo Vinti, Paris, Puf, 1983
[2] J. C. Michéa, L’insegnamento dell’ignoranza, Metauro ed., Urbino 2005
Tutto ciò ha determinato una sorta di standardizzazione dei processi educativi che si coniuga con quella contenutistica, la quale è peraltro sottoposta ad un esasperante e sistematico processo valutativo, che non fa che incoraggiare l’esaltazione di modelli competitivi e meritocratici a scapito del fiorire della Cultura. Questa era la situazione pre-pandemica a cui si è aggiunta la Didattica a distanza o DaD, la quale ha contribuito a esacerbare il fenomeno della dispersione scolastica e ad allargare così la forbice sociale. La fascia della popolazione povera è in costante aumento mentre gli interessi di altri prosperano, anche grazie alla corsa agli armamenti. Si proclama la pace ma si vendono armi. La giustizia sociale dov’è? Chi pratica l’autentica solidarietà? Inoltre, le ultime indagini rilevano che il consumo degli psicofarmaci va aumentando e anche l’ansia viene affrontata sempre più farmacologicamente, oggi ancor più che nel recente passato, mentre la cronaca riporta sempre più spesso storie di violenza fisica e psicologica a danno dei bambini, delle donne, della famiglia. La rabbia e la delusione hanno preso il sopravvento e alimentano “la guerra tra poveri”. Le istituzioni, attraverso gli enti di ricerca e di statistica, producono dati su dati per dirci quanto stia male la popolazione a livello micro e macro, di quante vittime stia mietendo il Covid, per informarci sui problemi locali e planetari legati alla povertà economico-educativa in espansione. Tuttavia non c’è cambiamento quando si continua ad agire in forma emergenziale, ovvero restando in superficie, o secondo le priorità dei ministeri che si succedono. È da tempo che molti esperti delle scienze umane e sociali denunciano la corrente dis-umana imperante, la medicalizzazione del sociale, il tecnocratismo dominante che hanno prodotto solitudine, mancanza di comunicazione, assenza di relazioni, meccanicismo, dipendenza da un mondo virtuale, competitività e meritocrazia. La pandemia ha solo moltiplicato gli effetti della mancanza di Educazione, di autentica attenzione all’esistere[1], ovvero a stare nel mondo, tra Altri da me. Esiste una soluzione? Certamente, ma solo se lo vogliamo! Mentre economisti, politici, virologi percorrono le loro strade, va re-intrapresa la strada dell’Educazione, l’unica possibilità di ripresa dell’umanità, ovvero il “condurre per mano” per rinascere. Come scrive il pedagogista Mario Pollo l’educazione, da un lato è rivolta ad aiutare la persona a scoprire le proprie potenzialità e, quindi, la propria unicità e dall’altro a sostenere l’espressione di questa unicità all’interno della cultura sociale in cui si sviluppa […][2]. Riprendiamo dalla scuola, dai bambini, investiamo sulle giovani generazioni, restituiamo loro la fiducia del domani, di un progetto di vita che è pure progetto sociale. Il bambino “è padre dell’uomo” (Montessori) ed è il Volto di una nuova umanità. Parliamo di Persone, emblemi di progettualità, autocostruzione, creatività, sviluppo, comunicazione, gestione emotiva, riconoscimento dell’alterità, fiducia, resilienza, capacità di accoglienza e accettazione del diverso. Basta osservare i bambini quando giocano e ne avremo la riprova. Alla flotta di scienziati che guidano la ricerca verso la risoluzione medico-sanitaria della pandemia deve affiancarsi una corposa ricerca educativa per individuare, ricercare, proporre e diffondere nuovi paradigmi esistenziali. Una ricerca che richiede unione, compartecipazione, condivisione all’interno del mondo delle scienze umane e sociali e non solo, allo scopo di provocare e promuovere un’autentica e benefica svolta sociale e politica. Le soluzioni non nascono come colombe da un cappello magico, vanno pensate, spogliate della retorica, rinnovate. Rinascere e ricostruire è l’obiettivo, a partire dalla consapevolezza che ogni Persona è portatrice di valori e di magnifiche idee. Ci attende un tempo nuovo, migliore o peggiore dipende da noi, il tempo della progettualità. Bisogna intraprendere un altro viaggio, quello di una Pedagogia dell’Esistenza, le cui peculiarità sono la relazione e la metabletica, ossia la scienza del cambiamento per imparare a stare nel cambiamento. Una Pedagogia dell’Esistenza, che ha come oggetto di studio l’Esistere del soggetto nella relazione con l’Altro da Me, mette al centro la Persona, nel ruolo di protagonista autodeterminato, autocostruttivo, autoeducato, che sa pensare prima di tutto, scegliere, agire: un processo educativo pluridimensionale, in cui la funzione pedagogica diventa essenziale. Abbiamo una sola certezza al momento: il ruolo determinante della scuola e la sua autorevole funzione educativa, imprescindibile dal tessuto sociale, economico, culturale, promessa di un futuro almeno sufficientemente buono. La scuola è una micro comunità dove s’impara a vivere secondo un’etica esistenziale, facendo leva sui valori che sono veicolati dalle parole, ognuna delle quali è portatrice di significati, storie, immagini. Ma occorre un’etica del linguaggio. Come adulti educanti, abbiamo il doveroso e impellente compito di restituire alle future generazioni la speranza, l’etica, l’amore per la res-publica. Dai nostri giovani emergeranno una classe dirigente, dei professionisti, dei lavoratori, ed è per questo che essi vanno ri-appassionati alla vita, alla comunità, alla relazione sociale, sin di primi anni di vita. Di fronte alla deprivazione attuale del sapere, mal compensata dalla volgarizzazione mediatica occorre una democrazia cognitiva (Morin): l’unica strada possibile, nel terzo millennio, verso la riumanizzazione dell’Esistere universale. Le nuove parole emergenziali sono: scuola, educazione, bellezza, solidarietà e giustizia, parole belle e intense che richiedono impegno e corresponsabilità ma, soprattutto, la volontà di rinascere a nuovo. C’è molto lavoro da fare![3]
“L’uomo, ritornato a sé, consideri quel che è in confronto a quel che esiste. Si veda come sperduto in questo remoto angolo della natura; e da quest’angusta prigione dove si trova, intendo dire l’universo, impari a stimare al giusto valore la terra, i reami, le città e sé stesso”, (Blaise Pascal)
[1] http://www.treccani.it, dal latino exsistĕre, der. di sistĕre ‘stare’, col pref. ex- ‘fuori’
[2] Pollo M., L’educazione: il mestiere possibile, la Rondine ed., Catanzaro 2010
[3] L’articolo ha fatto riferimento al testo di Luisa Piarulli, Tempo di educare, tempo di esistere. Verso una pedagogia dell’esistenza, Golem 2019