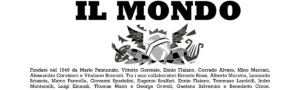CULTURA
TROPPI ANGLICISIMI NELLA LINGUA ITALIANA
Anna Antolisei
E’ diffusa la voglia di ostentare una disinvoltura poliglotta quando non se ne hanno nemmeno le conoscenze più elementari
Totalmente presi come siamo dall’assalto del recente Covid-19, dimentichiamo che, in circolazione, di virus meno letali ma ugualmente infettanti ce ne sono in abbondanza. Non occorre essere accademici della Crusca per notare quanto la lingua italiana venga costantemente vilipesa dall’infiltrazione di termini e di espressioni anglo-americane. E’ un delitto perché, malgrado non si possa razionalmente considerare l’italiano come l’idioma più bello del mondo, è però legittimo ammirarne tanto la ricchezza lessicale, quanto la particolare, armoniosa sonorità. Non a caso, l’italiano letterario nasce come ‘lingua del discorso amoroso’ sin dai tempi del dolce stil novo: cosa che indusse un inglesissimo poeta come John Milton a scrivere, in italiano: “Questa è la lingua di cui si vanta Amore”. Ma evitiamo di abbandonarci a gloriose riminiscenze e veniamo ad oggi, tempo di esubero di anglofilia nel linguaggio parlato e scritto. Qui si allude alla sovrabbondanza di inglesismi riscontrata da un’indagine statistica che dimostra come, dal 2000 a oggi, l’uso di termini inglesi nella lingua italiana sia aumentato del 773%. Una cifra enorme, inverosimile, mai riscontrata in nessun altro Paese dell’area occidentale. La conseguenza è che il povero idioma di casa nostra s’infarcisce di termini anglo-americani la maggior parte dei quali è perfettamente traducibile: si tratta, insomma, di lessemi usati per lo più impropriamente, spesso al limite del ridicolo. Ed è il fenomeno dilagante che fa scrivere a Corrado Augias: “Quel goffo cosmopolitismo linguistico… E’ diffusa la voglia di ostentare una disinvoltura poliglotta quando non se ne hanno nemmeno le conoscenze più elementari. Service tax, welfare, smart working, default…, esempi grotteschi unici al mondo. Ma siamo diventati matti?”. Accettando ovviamente alcune terminologie tecniche la cui versione inglese è d’obbligo, sì, forse siamo ammattiti, ma diventa comunque gioco forza domandarci come e perché tutto questo sia avvenuto in tempi così brevi e in una dimensione tanto generalizzata. C’entra forse il complesso d’inferiorità di gente dal passato immenso che oggi si sente decaduta? O è l’atavico, furbesco istinto di certo popolino ad ingraziarsi sempre la controparte più potente? Se si tratta di altro ancora è difficile a dirsi, ma qualche constatazione certa si può fare. Sappiamo, ad esempio, che la terminologia anglofila si spreca negli ambienti della politica e che, subito a seguire, abbonda nel mondo dell’informazione. Arrivano a rimorchio tutte le altre categorie, acritiche imitatrici di un linguaggio imbastardito, vittima del provinciale snobismo italiota. Politica e informazione, dunque: proprio quelle classi che dovrebbero rivolgersi alla nazione intera. In primis all’elettorato italiano che, come la nostra Costituzione sancisce, comprende tanto l’intellettuale radical-chic quanto il pastore delle Madonìe; tanto l’onorevole Santanchè quanto la mamma-casalinga di Voghera; tanto il colonnello in pensione quanto l’imberbe rockettaro. Sappiamo anche che, archiviato da parte dei nostri governanti il dovuto rispetto per le diversità di ceto e d’istruzione, non può costar loro troppa fatica dire “riforma del lavoro” invece di jobs act; oppure parlare di “revisione della spesa” piuttosto che di spending rewiew. E perché imporci un lock down piuttosto che un “confinamento”, o una “serrata” generale?
Ma è credibile che questa deriva sia dovuta a un minimo risparmio di sillabe, laddove quegli stessi oratori ci sommergono quotidianamente di spossanti arringhe e di eterni concioni? L’ipotesi è troppo incongrua, dunque chissà che a monte non vi sia la negazione di tutt’altra realtà. Dal 2018 sappiamo da statistica che solo il 43,6% degli italiani dichiara di conoscere la lingua internazionale. Siamo certi, per giunta, che una mera dichiarazione sia garanzia di verità? E se, sotto sotto, albergasse il falso convincimento di chi, avvezzo a sciorinare nel discorso un esubero di look, fashion, business, location, background, cult, mobbing, escort e via delirando, non sia convinto – povera anima! – di padroneggiare davvero la lingua di Shakespeare? Sta di fatto che il devoto italianista è sconfitto in partenza se persino il dizionario Hoepli inserisce il termine itanglese a sancire come il nostro idioma sia “caratterizzato da un ricorso frequente ed arbitrario a termini e locuzioni inglesi”. E il purista inorridisce ancor più quando, per iper-eccesso di zelo, l’inglese stesso viene “italianizzato” attraverso lemmi improbabili come brandizzare, biffare, performare, ecc; sino a venir meno quando incappa in quell’orripilante formula, per dire semplicemente “sempre”, che è il novello H24 (acca ventiquattro). Il purista, però, trova la sua rivincita rotolandosi dal ridere quando l’anglofilo si fa tradire dai cosiddetti “falsi amici” (sorry, dai false friends). Attenti, improvvisati anglofili, perché i falsi amici in agguato sono tanti. Ad esempio, close si usa per ‘vicino’ e non per chiuso; il culturist non è un patito della palestra ma un ‘allevatore’ o un ‘coltivatore’; eventually è usato per dire ‘infine’; l’incident non ferisce nessuno, è solo un ‘avvenimento’; lo scholar è il contrario dell’alunno, infatti sta per ‘erudito’; terrific, poi, si usa per ‘magnifico, fantastico’ e trivial non richiama alcuna volgarità perché significa ‘banale’, ‘insignificante’. Dopo di che, come ulterior vuol dire ‘recondito’ o ‘nascosto’, così volubility non c’entra per nulla con l’incostanza, ma significa invece ‘loquacità’. Ultimo avvertimento: oltremanica oppure oltreoceano, è meglio che l’anglo-maniaco non battezzi il proprio animaletto di casa Willy o Prick; chiamandolo per strada rischia una denuncia per oltraggio al pudore. Tirando le somme: perché chi mostra un’insofferenza grave per la corruzione dell’italiano viene spesso tacciato di conservatorismo, d’inattualità, di miopia sciovinista? Perché mai, se quando difendiamo l’italianità della cultura, dell’arte, della gastronomia e delle nostre eccellenze, nessuno ha nulla da ridire? C’è qualcosa di tanto diverso se si estende il discorso alla salvaguardia della lingua? Dubito si voglia negare che l’italiano è un bene comune, che rappresenta la nostra storia, le nostre radici, ciò che ci identifica e ci accomuna. Senza cadere nel fanatismo, pare però legittimo aspirare a un’inversione di tendenza; sollecitando i nostri governanti, presunti latori del buon esempio, a mostrare nell’eloquio se non un maggiore orgoglio nazionale, almeno più rispetto verso il popolo del Paese che rappresentano: gente forse poco poliglotta, ma di certo molto molto molto innamorata della propria terra.