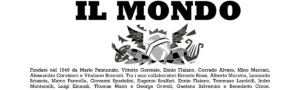SOCIETA’
La crisi dell’Occidente
Nunziante Mastrolia
Il risultato è che pezzi dell’Occidente si sono proiettati con grande velocità in avanti.
Che l’Occidente sia in crisi è ormai diventato un luogo comune: pare anzi, stando a quanto una serie di osservatori da diversi anni vanno affermando, che il modello occidentale in sé – Stato di diritto più economia di mercato – sia intrinsecamente bacato e quindi destinato al collasso. Eppure le prove a sostegno di questa tesi scarseggiano, sia che al concetto di Occidente si dia una interpretazione restrittiva, sia che gli si dia una interpretazione ampia. Infatti, anche se si considera l’Occidente solo una espressione geografica, questa include comunque i paesi più ricchi, prosperi e dinamici del pianeta, vale a dire Europa e Nord America. E lo stesso discorso si può fare se anche si volesse ricorrere ad una accezione estesa del concetto di Occidente, che in massima parte coincide con l’ideal-tipo popperiano di società aperta, in quel caso sarebbe necessario includere paesi come il Giappone, Taiwan e la Corea del Sud che hanno sperimentato un progresso spettacolare negli ultimi decenni. Tuttavia le coscienze collettive la pensano in maniera diversa. È evidente allora che c’è qualcosa che non va, se il sentimento prevalente delle opinioni pubbliche occidentali è quello della paura del futuro. Per dirla diversamente: se le società aperte occidentali continuano ad essere paesi attivi, creativi, vivi e liberi, perché i loro cittadini si lasciano prendere dall’angoscia del futuro e guardano con una certa speranza alle democrazie illiberali e ad alcuni regimi autocratici? E se la paura del declino è infondata, allora di che cosa le persone hanno paura? Partiamo da un punto. È possibile sostenere che la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, prodotti dalle società aperte occidentali, vale e dire gli unici luoghi dove convivono i diritti sociali (scuola e sanità pubblica) e libertà liberali (diritto all’eresia e all’errore), hanno avuto un impatto tale sul tessuto economico e sociale da produrre un salto di paradigma, da un’era fordista e un’era post-fordista, o, per dirla diversamente, da una economia industriale a un’economia della creatività o digitale. Il punto è che questo cambiamento del paradigma della produzione di beni e servizi ha riguardato soltanto il mondo della produzione, che dalle logiche fordiste è passato alle logiche post fordiste, o, se si vuole dirla diversamente, da una produzione industriale a una economia che ha il suo motore propulsivo nella creatività e nel digitale. Al contrario tutto il resto (città, scuola, istruzione, mondo del lavoro) continua a muoversi con logiche fordiste in un mondo che fordista non è più; e che per forza di inerzia continua a produrre un aggravamento dei problemi, visto che non è più connesso o funzionale alla sua macchina produttiva. Allo stesso modo, il sistema sanitario continua a ‘produrre salute’ in maniera fordista, vale a dire curando i malati (e non prevenendo che i sani si ammalino) senza personalizzare le cure e i controlli.
Il che, combinato con l’aumento strabiliante dell’età media, rischia di far lievitare sempre più i costi della sanità tanto da renderla insostenibile per le casse dello Stato. Stesso discorso vale per la scuola che continua a riempire la testa degli alunni di contenuti, quando sarebbe forse più utile, vista la velocità con cui i saperi evolvono, fornire strumenti per orientarsi nel mondo, stimolare la creatività e l’intraprendenza e, soprattutto, insegnare loro ad imparare o, per dirla con Stiglitz, “learn to learn by learning”. Ora, se la scuola pubblica e la sanità pubblica, che sono il cuore dello Stato sociale, continuano a essere impostanti secondo una logica fordista in un mondo che fordista non è più, allora vuole dire che siamo di fronte ad un dato di fatto: la mancata riforma, manutenzione e adeguamento dello Stato sociale ai tempi nuovi. I pubblici poteri, per dirla in altri termini, non hanno riformato quella mano pubblica che deve garantire i diritti sociali, vale a dire la macchina dello Stato sociale. Il risultato è che pezzi dell’Occidente si sono proiettati con grande velocità in avanti, producendo tecnologie e ricchezze delle meraviglie, mentre un’altra parte è rimasta indietro. Il che ha prodotto una spaccatura tra chi può permettersi di compare con le proprie tasche salute e istruzione e può fare il balzo e continuare a vivere prosperando nel nuovo mondo digitale. Chi non potrà farlo rimarrà invischiato in un mondo fordista destinato a scomparire. Se così stanno le cose, allora si può dire che il modello Occidentale non è in crisi. E quel qualcosa che non va deriva dal fatto che una sua parte, il progresso tecnologico ed economico, è andata più veloce del progresso sociale. Il che è dipeso dal mancato adeguamento ai tempi nuovi di quella istituzione che avrebbe dovuto garantire il rispetto dei diritti sociali, vale a dire la macchina istituzionale del Welfare State. In conclusione, le cause della crisi percepita vanno attribuite non nell’esaurimento del modello liberal-democratico o alla sconfitta delle società aperte, ma alla semplice e banale mancata manutenzione della macchina istituzionale che, a livello internazionale e a livello interno, avrebbe dovuto garantire il rispetto dei diritti sociali accanto alle libertà liberali. Il malanno, pertanto, è dovuto non al declino, ma alla crescita straordinaria che le società aperte stanno sperimentando. La notizia buona è che si tratta di un malanno curabile, la cattiva è che se non curato potrebbe diventare molto pericoloso, per la stabilità interna dei paesi occidentali, per la crescita economica e per l’ordine liberale internazionale.