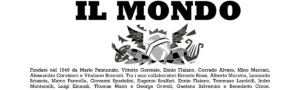RELIGIONE
LA DIVERSITA’
Francesco Curto
Occorre ridisegnare il rapporto Stato-Religioni, trattando il “fatto religioso” non come un argomento ma come un importante pilastro sociale.
Da un’osservazione della società moderna, appare evidente come il pluralismo religioso non sia affatto, come ritenuto da alcuni in passato, un fenomeno sociale transitorio o reversibile, bensì risulta essere un fatto profondamente radicato capace di ridefinire costantemente il contesto culturale di ogni Paese. Appare quindi evidente rivedere l’approccio alla diversità culturale e religiosa per ottenere nuovi risultati rispetto a quelli che nella storia dell’uomo si sono manifestati. Studiare quindi le diverse culture dell’uomo nelle loro varietà e convergenze, risulta fondamentale poiché scandisce il grado di influenza sulla natura e sulla società. Da quando l’essere umano comparve su questo pianeta, in ogni periodo ed in ogni luogo e sino ai giorni nostri, l’essere umano si è trovato ad affrontare e risolvere sempre nuovi problemi dettati dal contesto in cui si è trovato, dandosi delle regole di gestione ed organizzazione sociale volte a definire una convivenza pacifica all’interno della comunità, regole che qui possiamo chiamare “diritto”. Deve essere però chiaro che “diritto” è una nozione che non ha un corrispondente preciso in tutte le culture. Ad esempio, la sharia islamica, il fa della tradizione cinese, il dharma indiano non combaciano completamente con la nozione occidentale di “diritto”. Il diritto muta nel tempo e nello spazio e di esso occorre avere una visione dinamica. L’evoluzione, la variazione, il progresso, le migrazioni e le influenze culturali hanno creato costantemente degli squilibri nelle dinamiche umane, talvolta favorevoli ad ulteriori innovazioni (ovvero nuove variazioni). Le regole nate (ossia il diritto) sono state conseguentemente diverse nello spazio e nel tempo. E ciò si è verificato per un semplice fattore: la diversità. Questo vale per il reale materiale e per il reale culturale. La diversità proviene dalla variazione. La diversità può implicare incompatibilità e perfino conflitto (la variazione non ha creato, in natura, un “gruppo di amici”), portando il reale anche ad autodistruggersi con le proprie forze ed i propri mezzi. L’evoluzione biologica è imperniata sulla diversità dei percorsi e dei risultati. Ma senza la variazione l’homo habilis non sarebbe succeduto all’australopithecus e, se il diritto non fosse “esploso” con l’evoluzione umana, per far posto a mille sistemi differenti, esso sarebbe restato ciò che era al momento dell’umanizzazione dell’homo habilis, con una proprietà-possesso garantita dall’autotutela (ossia dalla forza del possessore), con i quasi-contratti nascenti dalle attività svolte in comune (come la caccia e la raccolta), con una gerarchia sociale incentrata sull’autorità-forza e sul prestigio di un personaggio dominante. L’uomo, quindi, si è evoluto per due milioni e mezzo di anni, attuando una evoluzione biologica e culturale. Un’evoluzione biologica che ha condizionato l’evoluzione culturale, ma che da un certo punto, è stata condizionata fortemente da quest’ultima. L’uomo, infatti, con le sue scelte culturali (dove costruire la propria casa, cosa mangiare, come cucinare, l’approccio all’invisibile o alle divinità, il modo di difendersi dal caldo o dal freddo, la modalità di scelta o rifiuto del partner, ecc.) ha continuamente premiato o condannato determinati sviluppi biologici. Nel mondo della biologia, sappiamo, le differenze sono irreversibili, ma nel mondo della cultura, invece, la differenza può essere eliminata mediante l’imitazione. In un certo senso, l’imitazione è un processo omologo alla selezione naturale, basato sul fatto che i molteplici modelli entrano in conflitto e uno di essi perde e scompare, mentre l’altro vince e si diffonde. Questi conflitti, insieme alla variazione, sono la molla di ogni mutazione. Nella dinamica della cultura, l’imitazione ha un posto di prim’ordine, sia se imposta o se spontanea (si pensi ai popoli che per amore o per forza hanno adottato la lingua latina, oppure, hanno dato applicazione al Codice Napoleonico). In tale processo di imitazione spesso vengono persi i particolarismi originari del modello culturale di partenza, i quali inevitabilmente faranno posto ad elementi culturali propri dei popoli in cui il modello culturale imitato si è diffuso. All’interno del modello culturale imitato/condiviso, si creano così dei particolarismi nuovi che, inevitabilmente, in virtù del contesto in cui il modello viene ad agire, creano altrettante nuove realtà e nuovi modelli culturali.
All’interno del modello culturale imitato/condiviso, si creano così dei particolarismi nuovi che, inevitabilmente, in virtù del contesto in cui il modello viene ad agire, creano altrettante nuove realtà e nuovi modelli culturali. In merito è emblematico l’esempio del Buddhismo che, nato in India, perde gran parte dei propri tratti peculiari originari (che lo vedevano come movimento spirituale della classe guerriera, contrapposto al movimento Jainista della classe dei mercanti, nonché al bramanesimo) per assumerne di nuovi in Cina (per lo più mutuati dal Taoismo), specificarsi e diffondersi con nuovi tratti distintivi in altri Paesi, anche qui perdendo alcune peculiarità originarie per assumere tratti di alcune religioni autoctone o filosofie.Lo stesso valga per il Cristianesimo, l’Islam ed altre religioni che hanno accompagnato l’uomo nel corso dei secoli. In sintesi, questi esempi di imitazione/unificazione non hanno prodotto modelli statici, proprio in ragione delle diversità insite nella natura e nelle culture e, se la storia dell’uomo ha insegnato qualcosa, sino a quando sopravvivrà il concetto di modelli culturali in conflitto e quindi di dominio di un modello culturale su un altro, l’unificazione ed i suoi risvolti (sopra citati) saranno la via che prevarrà su ogni altra, manifestandosi ciclicamente, in ogni dove, nelle diverse epoche che verranno. Oggi ci troviamo (nuovamente) in un contesto di sensibilità più elevate e attente alle peculiarità, pertanto, creare un contesto capace di disinnescare il modello del conflitto, radicando alti valori etici e morali di rispetto nei confronti delle diversità risulta fondamentale per non ripetere gli stessi errori del passato. Cambiare approccio e rispettare la diversità non vuole dire solo convivenza pacifica, ma tutela dei particolarismi insiti in ogni cultura e in ogni Credo. Come detto nel precedente elaborato (“Dove c’è il fumo c’è il fuoco: la libertà religiosa come segnale della presenza di democrazia”), per quanto attiene il nostro Paese, per raggiungere questo obiettivo occorre ripensare alla normativa vigente, rivedendo quella c.d. “comune” e adottando un corretto approccio per quella “speciale”, così come era stata pensata dai padri della Costituzione. Occorre ridisegnare il rapporto Stato-Religioni, trattando il “fatto religioso” non come un argomento assolutamente privato, ma come un importante pilastro sociale (portando equilibrio tra Ragione e Religione), riconoscendo l’importanza del sacro e come esso possa essere promotore (non unico) dello sviluppo umano. Ci troviamo, quindi, in un contesto problematico che, ad onor del vero, già in epoche passate si è verificato, quindi, chissà se oggi ripercorreremo gli stessi passi dei nostri avi. E’ indubbio che la diversità sia un elemento del reale e che, sicuramente, in un modo o nell’altro, tende a manifestarsi, ma a livello culturale e cultuale sta a noi, attraverso il confronto, ravvivando il dialogo e attraverso le nostre azioni, creare una società in cui sia disinnescata la logica del conflitto, perché in questa logica è insita quella del predominio di una cultura su di un’altra. Questo non vuol dire lasciare spazio a chi adotti un modello conflittuale, ma fare in modo che anche altri, nella nostra società, non siano posti nella condizione di creare conflitti ovvero che si creino conflitti per falle nell’approccio adottato, smettendo quindi di contrapporre “Verità” a “verità” e accettando finalmente l’esistenza delle “tante Verità” che non possono essere misurate tra loro. Nelle varie esperienze vissute all’interno del Comitato FEDINSIEME, è stato possibile, infatti (negli eventi di Spiritual Touch, Spiritual Life, Spiritual Food e Spiritual Sound), abbandonare il modello conflittuale (in ambito culturale e religioso), per abbracciare quello della collaborazione per fini condivisi, basati sui più elevati principi umani. Il percorso è lungo, ma non bastano singoli episodi per modificare il modello culturale, occorre un approccio dell’intera comunità che riaccenda il confronto sul tema e detti le basi per un nuovo inizio.